Massoneria, politica, giustizia, stragi: le clamorose accuse (poi ritrattate) dal pentito D’Urzo
Maxiprocesso Rinascita Scott: l’ultima informativa del Ros depositata dal pool di Nicola Gratteri riporta le sue rivelazioni e poi una lettera, rimasta finora segreta, in cui si smentiva

Le accuse, clamorose. Poi la ritrattazione, quasi immediata, attraverso però una lettera inviata al suo avvocato di fiducia rimasta finora segreta. Nove anni dopo, così arriviamo ai nostri giorni, la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro contatta lo stesso legale e chiede il suo ausilio per ricostruire, attraverso tutta la documentazione conservata nel suo studio, il percorso collaborativo di un pentito che, nel frattempo deceduto, ha portato con sé molti misteri: raccontano non solo della presunta appartenenza alla massoneria di politici e magistrati, ma anche retroscena inediti della stagione delle stragi. Ritrattò, il pentito, con una lettera il cui contenuto è rimasto riservato fino ad oggi e viene svelato nell’ultima informativa che il pool di Nicola Gratteri ha depositato nel maxiprocesso Rinascita Scott. [Continua in basso]
Il pentito D’Urzo

È una vicenda complessa. Il protagonista è Gerardo D’Urzo, originario di Sant’Onofrio, nel Vibonese, spirato nel 2014 all’età di 51 anni. Un collaboratore considerato attendibile e genuino, tra i pochi – secondo l’ex pm antimafia di Catanzaro Marisa Manzini – ad intraprendere anche un percorso di fede e di redenzione umana dopo i crimini commessi. D’Urzo era un uomo dei Petrolo-Matina-Bartolotta, cartello mafioso di Sant’Onofrio, che dalla fine degli anni ’80 ingaggiò una cruenta guerra di mafia contro i Bonavota. Prese parte alla strage dell’Epifania: 6 gennaio 1991, un commando giunse nella piazza del paese e scatenò una pioggia di fuoco; sul selciato rimasero due morti innocenti ed undici feriti. I killer si divisero e si dileguarono. D’Urzo fu braccato dall’equipaggio di una gazzella dei carabinieri, che all’epilogo di un tenace inseguimento riuscì ad arrestarlo. Condannato all’ergastolo, decise di collaborare con la giustizia, consentendo che si facesse luce su numerosi crimini, rivelando i legami tra la ‘ndrangheta vibonese e quella reggina, la presenza di alcuni tra i capi della destra eversiva italiana in Calabria sin dagli albori della strategia della tensione, deponendo in numerosi processi all’esito dei quali fu riconosciuta la sua attendibilità.
Correva l’anno 2009

Siamo al 19 dicembre 2009: Gerardo D’Urzo rende delle dichiarazioni esplosive alla Polizia penitenziaria nel carcere di Alessandria, manifestando gravi timori per l’incolumità sua, della sorella e dei nipoti. Afferma che le sue paure sono correlate a delle dichiarazioni rese in precedenza nel carcere di Monza. Oltre che di Giancarlo Pittelli – avvocato ed ex parlamentare della Repubblica, imputato chiave del maxiprocesso Rinascita Scott, nei cui confronti l’ultima informativa del Ros rappresenta una nuova carta prodotta dall’accusa – D’Urzo racconta della presunta appartenenza massonica di due magistrati, di un ex uomo di governo e di tre notabili catanzaresi. Racconta come l’ex uomo di governo, al tempo in cui era in auge, avrebbe addirittura preso parte ad un summit mafioso in una masseria tra Sant’Onofrio e Stefanaconi. Dice che nell’estate del 1984 avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale con un magistrato, ignorando però la professione che la donna svolgesse. Quattro anni dopo, quindi nel 1988, si sarebbe confidato con Pietro Carone, ucciso il 23 febbraio 2010, fratello di Saverio, ovvero il capobastone di Santa Domenica di Ricadi a sua volta assassinato il 12 marzo del 2004, che gli avrebbe detto: «Proprio con questa ti sei andato a mettere che già ce l’abbiamo nelle mani i Mancuso e noi ed è pure sposata e abita nella zona». [Continua in basso]
Angela Napoli, poi i Mancuso e i siciliani

D’Urzo poi racconta di un tale «Valensise» che, in compagnia di uno ‘ndranghetista della Jonica, avrebbe avuto un colloquio «a Palazzo Grazioli con l’onorevole Silvio Berlusconi». D’Urzo parla di presunte «promesse» fatte dall’ex premier, il quale – secondo quanto emerge dal verbale – sarebbe stato al corrente che «la bomba all’onorevole Angela Napoli gli è stata messa su mandato della cosca Pesce di Rosarno e della cosca Bellocco di Rosarno per fare un favore ad un politico». Il pentito racconta di aver incontrato nel carcere di Siano anche Giuseppe Mancuso, ovvero lo storico capo dell’ala più sanguinaria del clan di Limbadi, il quale gli avrebbe riferito di un «incontro con i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano» affinché aderisse alle stragi programmate da Cosa nostra all’Olimpico di Roma, in via dei Georgofili a Firenze e in via Palestro a Milano. Dice pure che, quando era detenuto all’Asinara, conobbe pezzi da novanta di Cosa nostra, come Antonino Marchese, uno dei cognati di Leoluca Bagarella a cui sarebbe «venuto per la testa di far saltare il Duomo di Milano».
L’esame del Ros
Il lavoro che il Ros Centrale fa su questo materiale è di grande scrupolo e correttezza istituzionale: «Su questo verbale – è scritto nella nota firmata dal maggiore Fabio Vincelli – c’è da fare una doverosa precisazione. Infatti, nel tentativo di ricostruire il percorso collaborativo del D’Urzo in termini di dichiarazioni rilasciate, codesto ufficio di Procura aveva richiesto al suo difensore dell’epoca, l’avvocato Claudia Conidi, di fornire al Ros i verbali a lei in possesso del D’Urzo. L’avvocato, a titolo collaborativo, aveva avviato una ricerca e trovato della documentazione, per cui contattò personale del Reparto per consegnare tali atti in data 24 luglio 2018». [Continua in basso]
«Ierinò mi disse di dire…»

Gli investigatori antimafia dell’Arma si rimboccarono subito le maniche per studiare il vasto carteggio e, sin dal giorno dopo la consegna, dallo stesso spuntò fuori una lettera che il collaboratore di giustizia inviò al suo avvocato il 26 novembre del 2009. È un dettaglio importante, perché si tratta di un giorno precedente a quello in cui (il 19 dicembre 2009) spiegò alla Polizia penitenziaria di Alessandria la decisione di interrompere la collaborazione con la giustizia, riferendo i presunti fatti che abbiamo appena riassunto, ma è altresì un giorno successivo a quello in cui quelle stesse circostanze, o una parte di esse, aveva messo a verbale, nel carcere di Monza davanti al magistrato incaricato dalla Dda di Catanzaro. D’Urzo chiedeva al suo legale di diffondere agli organi di informazione «tutto quello che avete nelle mani, cioè anche il fatto della massoneria del nuovo ordine dettomi da Ierinò Vittorio, che io dovevo accusare le seguenti persone…». E poi i nomi dei magistrati, dei notabili catanzaresi e dello stesso Pittelli. «Ma io non ho mai pensato che queste persone… – riportiamo il contenuto testuale della lettera – e non credo che fanno parte di questo sodalizio e devo denunciare tutte queste cose…».
Perché?
Resta, a questo punto, un nugolo di dubbi. Perché il pentito D’Urzo – il dichiarante «credibile» secondo plurime decisioni della magistratura e l’uomo spiritualmente redento raccontato dall’ex pm Marisa Manzini in una sua pubblicazione – avrebbe mentito in quei verbali di fine 2009, affermando circostanze così clamorose? Chi e perché, se davvero ha mentito, lo avrebbe indotto? E chi è Vittorio Ierinò ovvero l’uomo che, attribuendo verità alla missiva inviata all’avvocato Conidi, lo avrebbe spinto ad accusare persone che non conosceva?
Chi è Vittorio Ierinò
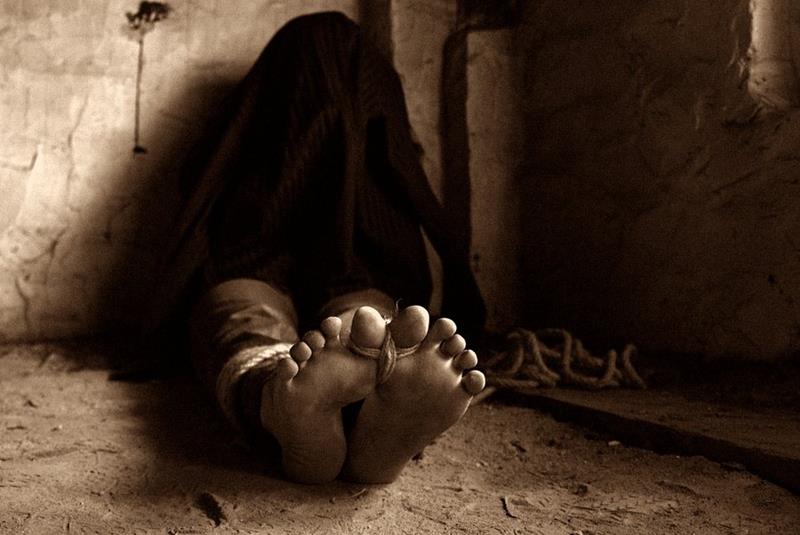
La letteratura giudiziaria sulla ‘ndrangheta conosce soprattutto un Vittorio Ierinò. Fratello del boss Peppe Ierinò, detto “Manigghjia”, è attualmente in carcere per l’omicidio di Salvatore Germanò, ex collaboratore di giustizia assassinato con un colpo di pistola alla testa il 18 luglio del 2014. Ierinò è a stato sua volta una gola profonda della ‘ndrangheta. Appartenente all’omonimo clan di Gioiosa Jonica, figlio del capostipite Francesco, nel 1991 fu coinvolto in prima persona nell’ultimo clamoroso rapimento della stagione dei sequestri orditi dall’Anonima calabrese, quello di Roberta Ghidini, i cui retroscena, in parte già noti, sono stati recentemente dettagliati dal pentito Nicola Femia, che ha svelato una storia di torbide relazioni tra mafiosi e apparati dello Stato, in parte già confessata dallo stesso Ierinò. Fu proprio lui, tra l’altro, nella sua turbolenta parentesi da collaboratore, a raccontare come Totò Riina avesse vissuto un periodo da latitante ad Africo vestito da prete. Una leggenda, questa, che poi assurse quasi a verità storica una volta messa a verbale.






