L’INTERVISTA | Vito Teti a tutto campo: «Per ricostruire l’identità calabrese serve una memoria sovversiva»
Dal sentimento religioso dei calabresi alle vicende più strettamente vibonesi, da Natuzza all’Italia dei paesi. L'antropologo e docente dell’Unical fra presente, passato e futuro giudica il suo "impegno politico un errore"
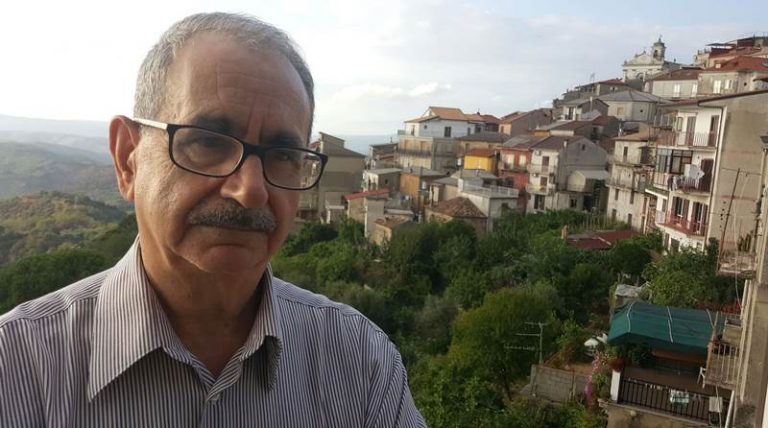
Su quel che resta della Calabria ci ha scritto un altro libro, il ventesimo o giù di lì. E poi centinaia di articoli, saggi, note a margine di una vita passata a indagare l’identità calabrese fuori dai soliti stereotipi a base di peperoncino e capa tosta. Vito Teti, l’antropologo di San Nicola da Crissa, docente dell’Unical con mille riconoscimenti e collaborazioni, è un’autorità in materia di calabresità, quella vera. Nel suo ultimo lavoro – ‘Quel che resta: l’Italia dei paesi tra abbandoni e ritorni’ (Donzelli Editore, 2017) – ha cercato ancora una volta di mappare le contraddizioni, le suggestioni e le opportunità che offre la sua terra, interrogandosi su «frammenti, schegge, periferie che sembrano marginali ma sono invece uno straordinario giacimento culturale di simboli e di idee che potrebbero essere utilizzati per rifondare le nostre comunità». Perché se c’è una cosa che emerge prepotentemente dal suo libro, già dalla copertina, è la necessità di ricostruire. Anzi, di costruire. Finalmente.
I piccoli centri continuano a spopolarsi. È davvero ancora possibile riedificare la nostra identità?
«Non è facile. Lo spopolamento – spiega l’antropologo – non è un problema risolvibile a colpi di slogan e retoriche identitarie. L’abbandono dei paesi, delle campagne, è un problema cruciale, demografico, economico, culturale, che coincide con il momento storico che vive il mondo. Soltanto se riusciremo a percepire la memoria in una chiave sovversiva, capace di ridare nuova vita a ciò che è stato scartato dalla storia, solo allora potremo procedere in avanti senza restare ancorati al passatismo più deleterio».

Perché in Calabria sembra tutto più difficile?
«Il motivo è che in questa regione il legame tra passato e presente si è interrotto in maniera drammatica, drastica. È come se la Calabria fosse passata da una condizione arcaica a una postmoderna, saltando la modernità. C’è una lacerazione che va ricucita».
E poi c’è il Vibonese, che a volte sembra la Calabria della Calabria…
«È vero. La provincia vibonese esprime una drammaticità maggiore rispetto al resto della regione, perché qui è ancora più grande lo scarto tra le potenzialità delle risorse (turistiche, paesaggistiche, archeologiche, culturali) e il fatto che non vengano tramutate in ricchezza. Forse perché i paesi sono troppo sfaldati, perché scontiamo antiche e nuove divisioni, perché il ceto politico si è dimostrato più inadeguato rispetto ad altre aree della Calabria, dove, nonostante gli scempi e le devastazioni, qualcosa è stato creato».
Ma c’è davvero la consapevolezza di questi limiti?
«No. La memoria viene spesso invocata come oggetto di celebrazione, ma non viene mai indagata e riconosciuta nella sua sostanza. Ad esempio, studiare la figura di Gioacchino Murat significa indagare su un personaggio importante, controverso, che già esprimeva una tensione per l’unità d’Italia ed ha alimentato i primi aneliti risorgimentali a Pizzo. Invece, tendiamo a celebrare le glorie locali, ma senza mai indagare sotto la superficie. Per fare un altro esempio, che senso ha oggi impelagarsi su Borbonici e Piemontesi? A che serve l’esasperazione moralistica che racconta di un Sud sfruttato e abbandonato?».

Ecco, appunto: a che serve?
«Solo ad assolvere i gruppi dirigenti odierni. Significa sfuggire alle nostre responsabilità. Un atteggiamento che negli ultimi tempi ha prodotto una sorta di leghismo al contrario che contribuisce ad alimentare il vittimismo».
Sono passati 10 anni da un suo famoso articolo che fu ribattezzato “Manifesto per una nuova Calabria”. Cosa resta di quelle esortazioni?
«In quello scritto mettevo in guardia dalla tendenza dei calabresi a dare sempre la colpa a qualcun altro, rifugiandosi nell’autoreferenzialità e ignorando i propri limiti. Purtroppo, da allora la situazione non è migliorata, anzi è peggiorata. Ecco perché trovo delirante che un consiglio regionale a guida Pd porti in discussione la proposta dei grillini sull’istituzione di una giornata della memoria per ricordare i calabresi morti dopo l’unificazione d’Italia. Un razzismo alla rovescia. Paradossalmente quello che non è riuscito alla Lega Nord prima rischia di riuscire ai leghisti meridionali di oggi».
Il suo rapporto con la politica è sempre stato discontinuo. È stato due volte candidato al Parlamento prima per il Pci nel 1987 e poi per il Pd nel 2006, oltre ad aver rivestito la carica di assessore provinciale alla Cultura. Quale sentimento nutre oggi per la politica?
«Di enorme delusione. Ho iniziato a fare politica alla fine degli anni ‘60, convinto che la politica, quella vera, servisse a migliorare il mondo. Ben presto, però, ho maturato la convinzione che sono gli uomini più che le appartenenze partitiche ad essere decisive. Oggi considero un errore il mio impegno politico, perché io ed altri che la pensavano come me abbiamo finito per avallare partiti e gruppi che non erano interessati a cambiare le cose, ma solo ad acquisire potere».
Cosa la disturbava di più?
«La doppiezza, la falsità. Le riunioni politiche erano estenuanti perché si girava a vuoto. C’era una sorta di doppio registro: persone alle quali ero legato da un rapporto amicale dicevano una cosa ma ne pensavano un’altra. Questa cosa ancora mi riempie di amarezza, perché mi sono reso conto che l’intellettuale era visto come un’utile idiota, senza una reale volontà di sfruttarne le competenze».

Anche quando nel 2008 rivestì la carica di assessore alla Provincia di Vibo Valentia fu così?
«Un’altra cocente delusione. All’inizio pensavo sinceramente di poter fare l’assessore alla cultura, invece chi governava non aveva alcuna sensibilità per queste tematiche. Un problema con il quale ci scontrammo subito io e Damiano Silipo (l’altro professore universitario chiamato in giunta dall’allora presidente Francesco De Nisi, ndr)».
Quale episodio le fece capire che non faceva per lei restare alla Provincia?
«Fui rimproverato per aver partecipato in qualità di assessore alla cultura a un incontro sull’opera di Renoir organizzato da un sindaco che però era sgradito a un altro assessore provinciale in carica. Ero andato in casa del “nemico” e non mi fu perdonato. Ridicolo. Ma la goccia che fece traboccare il vaso fu la gestione dei fondi annuali destinati alla cultura, appena 60mila euro a fronte di 300 richieste di contributo. Invece di dare inutili briciole di poche centinaia di euro a tutti, proposi di organizzare un unico grande evento. Ma le resistenze furono fortissime, non solo da parte di chi governava, ma anche dei governati. Una logica assistenziale che coinvolgeva tutti. Se il sistema continua a peggiorare è perché ci sono grandi responsabilità anche nella società civile».
Perché qui da noi, e al Sud in generale, i movimenti populisti sembrano attecchire di meno?
«Il motivo è che la vecchia classe dirigente tiene ancora in mano le clientele e, di contro, a livello locale i rappresentanti dei movimenti populisti non mi pare che abbiano un rapporto molto stretto con il territorio, né mi sembra che siano portatori di un messaggio di vera rottura. Non vedo, ad esempio, da parte dei grillini calabresi una vera posizione antagonista ai partiti tradizionali, al contrario di quanto avviene a livello nazionale».

Anche in Calabria, terra di emigranti, si comincia ad avvertire insofferenza e paura verso chi giunge dalle zone martoriate del mondo. Il nostro passato non dovrebbe renderci più tolleranti verso questi fenomeni?
«Ricordo l’entusiasmo sincero con cui anni fa i primi profughi curdi venivano accolti a Riace. Nessuno si sentiva invaso. Allo stesso modo, quando in passato sono arrivate le donne rumene, ucraine o i braccianti bulgari non c’era la sensazione di un’emergenza e queste persone sono riuscite a integrarsi. Oggi i timori vengono generati in parte dal racconto fortemente allarmistico dei media, ma soprattutto dall’approssimazione con cui le istituzioni gestiscono i fenomeni migratori. Se concentri migliaia di immigrati nei centri d’accoglienza e poi lasci che queste persone se ne vadano in giro senza avere nulla da fare, è ovvio che la gente cominci ad avere paura. Sono convinto che se ci fosse maggiore capacità gestionale, le singole comunità sarebbero pronte ad ospitare un numero contenuto e controllato di migranti».

Lei ha sempre stigmatizzato i tentativi della Chiesa di sopprimere alcune tradizioni popolari. Crede che nelle tensioni delle ultime settimane a Paravati, tra la fondazione di Natuzza e la Diocesi, ci sia questa volontà di riaffermare il proprio primato?
«Sono due questioni diverse. Ciò che non condivido è la volontà della Chiesa di controllare tradizioni che in passato ha invece alimentato. Ad esempio, chiudere i santuari ai suonatori della tradizione musicale calabrese trovo che sia un atteggiamento violento, che contradice la predicazione evangelica. Per quanto riguarda Natuzza, che si creda o meno, è indubbio che si tratta di una figura immensa e la fondazione a lei ispirata non può operare senza la presenza e il controllo della Chiesa. Su tutto, però, mi auguro che il culto di Natuzza non venga mercificato e non si inneschino processi di consumismo del sacro come è avvenuto per Padre Pio. Da laico e da credente a modo mio non sopporto lo spreco di danaro per i festeggiamenti, i fuochi, le celebrazioni esasperate. Tutte cose che niente hanno a che fare con il sentimento religioso più autentico».





